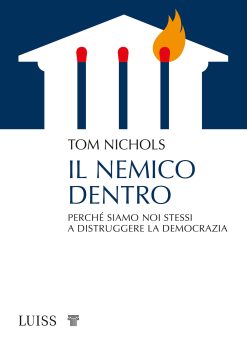Dove ha fallito la democrazia? La risposta che Tom Nichols dà in Il nemico dentro ha la forma di un’altra, scomodissima domanda: e se invece fossimo noi a non aver superato la sua prova? In questo estratto tratto dal libro, Nichols riflette sul ruolo di internet come medium prediletto per indebolire i sistemi democratici.
__________________________________________________________
Non mi piace la cucina indiana. Forse lo sapete già. Lo sanno anche milioni di persone in tutto il mondo, e il fatto che forse lo sapete è un problema. In verità, è una strana storia che costituisce un esempio perfetto di come la tecnologia ci stia inducendo all’autodistruzione. Il mio problema è cominciato, come tutte le storie avvincenti di ferite autoinflitte nel Ventunesimo secolo, con i social network. Un tranquillo sabato pomeriggio alla fine dell’autunno del 2019 un giovane di nome Jon Becker ha chiesto agli utenti di Twitter di postare le loro opinioni alimentari più controverse, e hanno risposto migliaia di persone. C’è stato il consueto odio per la maionese, un po’ di malumore nei confronti della lattuga e persino qualche attacco ai sandwich con burro d’arachidi e marmellata. Non si tratta proprio di opinioni controverse: per decenni in America si è combattuto l’equivalente di una guerra religiosa per l’ananas sulla pizza e il ketchup sugli hot dog. Io però ho deciso di puntare al primo posto in classifica. Ho dichiarato che non sopportavo la cucina di un popolo composto da oltre un miliardo di persone. E, giusto per essere irritante, ho aggiunto che non poteva piacere a nessun altro. “Penso che il cibo indiano sia terribile”, ho scritto, “e che fingiamo che non lo sia”. (L’ultima parte era una battuta tagliente rivolta ai miei amici americani che mi trascinano ripetutamente in ristoranti indiani e poi insistono per dirmi quanto amano il cibo mentre si asciugano il sudore dalla fronte e ingollano acqua).
Non sono mai stato in India e quindi la mia esperienza è limitata, ma semplicemente non mi è mai piaciuta quella che viene spacciata per cucina indiana negli Stati Uniti e in Europa, e i miei amici considerano questa mia avversione la dimostrazione di un palato provinciale e poco raffinato. All’inizio le reazioni sono state bonarie e divertenti. “Non hai le papille gustative?”, mi ha chiesto la celebre conduttrice di Top Chef Padma Lakshmi. L’ex procuratore generale degli Usa Preet Bharara si è offerto di portarmi in un ristorante indiano e di darmi una mano a scorrere il menù. Neal Katyal, illustre studioso di giurisprudenza indiano-americano (nonché mio ex allievo all’università a Dartmouth) ha postato la risposta più tipica di Twitter: “Unfollow”.
Poi le reazioni hanno assunto toni più cupi. Sono stato accusato, in varie sfumature di furia squilibrata, di fare il gioco degli stereotipi sugli indiani e di favorire una storia di oppressione. Qualcuno si è spinto fino a inventare storie sulla mia probabile nostalgia per i tempi del Raj. (Per la cronaca, non sono cresciuto come un figlio dell’Impero, ma sono figlio unico. Presumo sempre che a nessuno possa piacere qualcosa che a me non piace). Altri hanno persino suggerito che fossi un sostenitore del genocidio. Il lunedì mattina dopo il mio tweet del weekend, mi sono svegliato e ho trovato un’email di un collega indiano che mi diceva che in India ero finito sui notiziari. Nelle quarantotto ore successive mi sono ritrovato sulle pagine e sugli schermi del Times of India e altri giornali indiani, della BBC in Gran Bretagna, del Washington Post e di Fox News negli Stati Uniti, e di RT in Russia. Sia Fox sia RT, naturalmente, mi hanno presentato come un eroico professore bianco che rifiutava di piegarsi al multiculturalismo della massa.
Sono bianco, sì, ma non stavo cercando di dire qualcosa sul multiculturalismo. Piuttosto, stavo dimostrando che mi irrito facilmente per le cose che non mi piacciono. Quando ho cominciato a ricevere email minatorie, però, in cui mi si diceva che dovevo letteralmente morire per aver scherzato con il cibo indiano, mi sono chiesto – e non per la prima volta – quando la nostra società globale iperconnessa fosse diventata tanto bizzarra e pericolosa. Non era la prima volta che ricevevo minacce di morte e molestie di altro tipo, ma di solito erano state provocate da qualcosa che avevo scritto riguardo a temi politici più seri. Ora la gente mandava email a un professore di mezza età relativamente sconosciuto, nel Rhode Island, augurandosi la sua rapida dipartita a causa di un’affermazione casuale sul cibo fatta su Twitter.
La mia esperienza del Grande scandalo del cibo indiano del 2019 è stata relativamente leggera in confronto ai processi subìti da altre persone grazie al miracolo dei social network. La nostra capacità di comunicare all’istante, anonimamente e senza riflettere ha immortalato momenti di stupidità (anche da parte mia) che in passato sarebbero giustamente passati inosservati. In alcuni casi gli effetti sono stati molto gravi: vite innocenti sono state messe in pericolo in casi di scambio d’identità o per informazioni inesatte – e talvolta intenzionalmente fuorvianti – sulla sicurezza pubblica, per questioni che vanno dagli incidenti con le armi da fuoco alle informazioni sul Covid.
Peggio ancora, ci sono dei malintenzionati, dagli Stati ai politici imbroglioni, che ormai usano internet come medium prediletto per indebolire le elezioni democratiche in tutto il mondo.
Il tema dell’intervento straniero è troppo vasto per affrontarlo qui: in qualità di esperto di Russia, so che il governo russo e altri sistemi autoritari sono lieti di sfruttare le divisioni sociali nelle democrazie. Ma in fin dei conti il problema è degli utenti e dei consumatori, non dei regimi nemici che avvelenano i pozzi. (Ho scritto diffusamente del problema di internet e del suo effetto sulla verità e sull’autorevolezza del sapere in La conoscenza e i suoi nemici, e non intendo riprodurre qui tutte le mie argomentazioni). Questi attacchi sfruttano le nostre divisioni e rimostranze, la nostra vanità e il nostro tedio.
A volte si tratta di operazioni limitate contro singole figure o partiti politici, ma in alcuni casi diventano incendi distruttivi come il movimento QAnon, che ha seminato il panico morale basandosi su una folle teoria del complotto riguardo al sacrificio di bambini e alla pedofilia e che nel 2020 portando più di un politico squilibrato nelle aule del Congresso degli Stati Uniti. L’aumento dei venditori di complotti online ha avuto anche altre conseguenze nel mondo reale. Il 6 gennaio del 2021 la promessa di una connessione globale si è trasformata in un incubo civile quando migliaia di persone hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Usa, invadendo la Camera e il Senato e ferendo oltre cento agenti di polizia in una delle giornate peggiori per i danni alle forze dell’ordine dagli attentati dell’11 settembre 2001. I rivoltosi non erano persone senza diritti o oppresse riunite in un’assemblea pacifica. Un’analisi dettagliata condotta da due studiosi dell’Università di Chicago sui partecipanti che sono stati arrestati ha evidenziato invece che la rivolta di gennaio è stata vissuta come una gita in campeggio per americani di mezza età appartenenti al ceto medio:
L’età media degli arrestati che abbiamo esaminato è 40 anni. Due terzi hanno 35 anni o più e il 40 per cento è composto da proprietari di aziende o colletti bianchi. A differenza dello stereotipo dell’estremista, molti dei presunti partecipanti all’insurrezione del Campidoglio hanno tanto da perdere. Sono amministratori delegati, negozianti, medici, avvocati, informatici e commercialisti. A sorpresa, i documenti processuali indicano che solo il 9 per cento di loro è disoccupato. In passato, tra i sospettati estremisti di destra che abbiamo analizzato, il 61 per cento aveva meno di 35 anni, il 25 per cento era disoccupato e quasi nessuno aveva un lavoro impiegatizio.
In altri termini, si trattava di una “sotto-borghesia” annoiata, un ceto medio narcisista e per lo più benestante, con le tasche piene e la mente vuota, che sosteneva a parole la democrazia ma non nutriva alcun interesse nei suoi confronti se i risultati delle elezioni democratiche non la soddisfacevano. Questi insorti sono arrivati a Washington dopo aver vomitato per anni complotti e meme stupidi su internet, e poiché avevano partecipato a lungo alla vita politica attraverso uno schermo erano stranamente scollegati dalla gravità delle loro azioni. Hanno devastato la sede del governo e nel frattempo si guardavano sullo schermo del telefono e postavano freneticamente aggiornamenti sui loro account Instagram e Facebook, cosa che poi, ovviamente, ha agevolato la loro cattura. Una di loro ha raccontato al suo pubblico che, “viva o morta”, sarebbe entrata in Campidoglio, ma che una volta tornata in Texas tutti avrebbero dovuto ricordare che era un’ottima agente immobiliare bravissima a vendere le loro case. (Poi ha chiesto la grazia al presidente Trump). Un’altra, dopo l’arresto, ha chiesto al tribunale di essere rilasciata per poter partecipare a una “esperienza di fraternizzazione con i colleghi” in un resort del Messico.
Quasi tutti sembravano genuinamente sconvolti del fatto che la morte e la devastazione provocati dalla trasformazione della loro Woodstock antidemocratica alimentata dalla rete in una violenta insurrezione in stile Altamont potessero avere conseguenze serie. Questa violenza contro il sistema costituzionale americano è stata la pubblica espressione di una religione eccentrica, di un culto che sarebbe potuto emergere ovunque ma che poteva crescere soltanto nel pantano di un Paese iperconnesso. I suoi seguaci si sono schierati gli uni con gli altri sui social network, eleggendo a loro profeti e alti sacerdoti gli opinionisti delle TV via cavo. Il loro oracolo, il loro testo sacro, era il feed di Twitter del presidente degli Stati Uniti, che usava il potere del collegamento istantaneo per dar loro in pasto una storiella dopo l’altra su un’elezione rubata. Mentre quei folli ululavano e intonavano slogan nella galleria del Senato e altri sporcavano con escrementi le sale di marmo del Campidoglio, il potere e la promessa del coinvolgimento non sembravano tanto una forza di pace e democrazia, quanto una bandoliera di granate tra le mani di bambini ferini. Ancora una volta, come l’umanità è riuscita a fare con tutto, dal fuoco all’energia nucleare, abbiamo trovato un ottimo strumento che può far progredire la civiltà umana. E ancora una volta rischiamo di usarlo per distruggere noi stessi.
La possibilità della connessione, che poco tempo fa era un prodigio e una fortuna, è diventata una maledizione.
Già solo le dimensioni della nostra interazione con il mondo virtuale e la velocità con cui quel mondo ci ha avvolti hanno creato uno spazio vasto e tuttavia solitario, in cui siamo allo stesso tempo troppo connessi e troppo isolati. Interagiamo con milioni di altre persone quando ci pare e quando ci conviene, mentre ripuliamo le tracce della loro presenza attraverso le interfacce antisettiche delle app di messaggistica e dei social network. Non abbiamo bisogno degli altri per molto tempo: se siamo in cerca di un passatempo, possiamo semplicemente chiedere al nostro telefono o computer di aprirci un tavolo di blackjack o di trovarci un compagno per giocare a scacchi, e se non ci sono umani disponibili intervengono le macchine e ci arrangiamo. Se cerchiamo una conversazione, possiamo sputar fuori i primi pensieri che ci passano per la testa a nessun destinatario particolare o a tutto il mondo. Persino la nostra vita sessuale è diventata virtuale al punto in cui possiamo ingannare il tempo sull’autobus rifugiandoci nella pornografia, ignorando il disagio delle persone sedute accanto a noi.
La capacità di inviare e ricevere quantità infinite di dati, dalla televisione via cavo ai messaggi di testo, è uno dei progressi scientifici più importanti della storia umana, ma come tanti altri avanzamenti passati, c’è stato un prezzo da pagare. La democrazia liberale richiede pazienza, tolleranza e prospettiva, ma queste qualità sono inondate da fiumi di esperienze sensoriali (sarebbe troppo definirle “informazioni”). La possibilità continua di sbirciare nelle vite dei nostri vicini, di confrontarci con gli estranei, di mantenere un contatto costante con tutto il pianeta, giorno e notte, è innaturale e spinge la mente umana ben oltre la sua capacità di ragione e riflessione. La scala del problema è quasi impossibile da cogliere. L’iperconnessione ha invaso le nostre vite in modi di cui non ci rendiamo neanche conto e che non comprendiamo appieno. Anche chi cerca di evitare questa connessione non può evitare gli altri membri della comunità che sono connessi e sovralimentati.
Pensiamo alle dimensioni e alla portata dei social network: Twitter, nel momento in cui scrivo, ha più di 325 milioni di utenti. Facebook ne ha oltre due miliardi e mezzo, e ormai è un prodotto come la “TV via cavo”, che non ho bisogno di spiegare a un lettore moderno. A questo punto probabilmente Facebook è incontrollabile persino per i suoi creatori: la giornalista Adrienne LaFrance l’ha definito una “macchina dell’apocalisse”, perché gli algoritmi distruttivi del social network agiscono ormai quasi senza alcun intervento umano e Facebook si propone di diventare “l’(unica) esperienza de facto di internet per le persone di tutto il mondo”. Ma Twitter e Facebook sono soltanto due delle punte più alte di diversi giganteschi iceberg. Al giorno d’oggi chiunque possieda uno smartphone o un account di posta elettronica è “connesso”, e stiamo parlando di un sacco di persone. Nel 2012 circa un miliardo di persone nel mondo possedeva uno smartphone; nel 2020 il numero si è quasi quadruplicato, fino a comprendere quasi tutti gli americani.
Analogamente, più di metà della popolazione del pianeta ha un account di posta elettronica. E non ci limitiamo a mandare messaggi e a tenere calendari. La società che secondo alcune stime è al terzo posto per portata e influenza sulla società, appena dopo Facebook e Twitter, ma prima di Microsoft, Apple e Amazon, è Pornhub, il sito di intrattenimento per adulti che racimola 3,5 miliardi di visite al mese. Di nuovo, questo livello di connettività è in astratto un risultato straordinario. È una prodezza scientifica che aiuta gli esseri umani a restare in contatto reciproco, per non parlare dell’accesso che offre a diverse possibilità, dalle opportunità di lavoro ai servizi d’emergenza. Ma ciascuno smartphone e account di posta elettronica è anche un tubo che perde da cui fuoriescono molti liquami politici, sociali e intellettuali. Nel 2016 uno studio del Pew Research Center ha evidenziato il fatto che quasi non c’è modo di usare la tecnologia moderna solo come uno strumento, isolato dal mondo emotivamente sovraccarico del cyberspazio, soprattutto non i social network.
Nelle interazioni faccia a faccia, gli americani possono tentare (e spesso lo fanno) di tenersi alla larga da coloro con cui sono in forte disaccordo. Ma gli ambienti online dei social network presentano nuove sfide. In questi spazi gli utenti possono imbattersi in affermazioni che potrebbero ritenere estremamente controverse o offensive, anche quando non si impegnano in prima persona per rintracciare questi materiali. Anche le zuffe politiche possono invadere le vite degli utenti quando i commenti su argomenti scollegati si trasformano in accesi conflitti o litigi tra le parti. Farsi strada tra queste interazioni può essere particolarmente teso, alla luce della complessa miscela tra amici intimi, familiari, conoscenti distanti, collegamenti professionali e figure pubbliche che compone la rete di contatti online di molti utenti.
Possiamo tentare di convincerci che preferiamo non entrare in relazione con il mondo online, ma il mondo online entra costantemente in relazione con noi, che lo vogliamo o meno e che ci piaccia o meno.
Il giornalista Yevgeny Simkin ha sintetizzato la situazione in un’espressione concisa e terribile, anche se forse esagerata: “Tutti i mali moderni, sociali, politici e sociologici si possono far risalire ai social network”. Non tutti sono così pessimisti. David Shor, analista di dati americano impegnato in cause progressiste, osserva che molti cittadini non sono connessi al mondo virtuale come potremmo pensare.
L’elettore medio delle politiche ha circa 50 anni, quello delle elezioni di midterm o delle primarie è più vecchio. Non ha una laurea. Guarda circa sei ore di TV al giorno, in media; ci sono persone che ne guardano di più. In genere non legge giornali di parte. Per lo più si informa ancora grazie a fonti tradizionali. Guarda quello che trasmette ABC Nightly News. Forse vede qualcosa su Facebook, ma per lo più sui media tradizionali.
Shor però sottovaluta il problema. La realtà è molto di più che “vedere qualcosa” su Facebook o altri siti internet. Oggi il numero di persone connesse è più alto che in qualsiasi altro momento storico, e l’elettore medio di Shor sta marinando in una cultura le cui priorità spesso vengono definite dall’iperconnessione. Sperare che tutto ciò rimanga distante dai cittadini comuni equivale a essere ottimisti e sperare che un uomo che non ha mai toccato una sigaretta in vita sua corra rischi minori di malattie ai polmoni ignorando che è un minatore e vive in una casa piena di gente che fuma.
___
Da Il nemico dentro. Perché siamo noi stessi a distruggere la democrazia di Tom Nichols. In alto, foto di Robynne Hu – Unsplash.