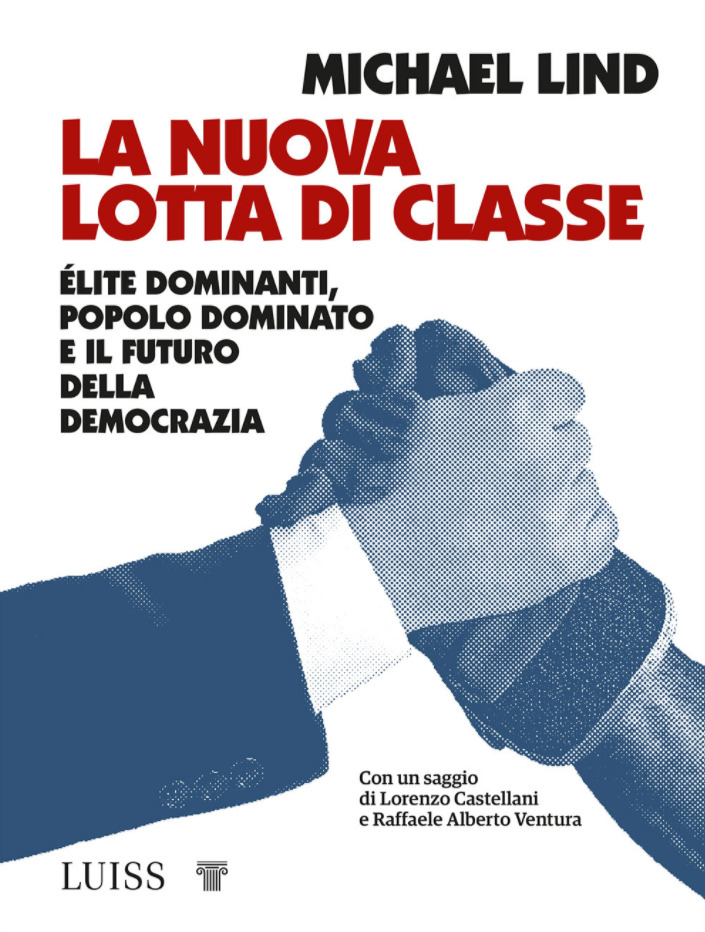Leggenda vuole che, la sera del 14 luglio 1789, un duca abbia informato il re di Francia Luigi XVI della presa della Bastiglia. “Si tratta dunque di una rivolta?” chiese il re. “No, maestà: è una rivoluzione” rispose il duca.
Il 23 giugno 2016 l’elettorato britannico ha approvato in maggioranza il referendum sulla Brexit che prevede l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Pochi mesi dopo quel terremoto politico – l’8 novembre 2016 – si è verificato qualcosa di ancor più sconvolgente: l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.
Da allora, in tutta Europa i partiti di centro hanno perso elettori a vantaggio di partiti e uomini politici secondari, in qualche caso di sinistra ma più spesso della destra populista e nazionalista. Nell’estate 2018, in Italia è salita al governo una coalizione formata dalla Lega, un partito populista di destra, e dal Movimento 5 stelle, un partito antiestablishment. In Germania, i socialdemocratici di centrosinistra sono implosi, perdendo elettori a favore di nascenti movimenti di destra e di sinistra. Altre nazioni, fino a quel momento ritenute immuni al populismo nazionalista – come Svezia, Germania e Spagna – hanno assistito all’ingresso nei rispettivi parlamenti di partiti populisti in ascesa.
Sotto il governo di Emmanuel Macron, ex funzionario civile e banchiere d’affari che nel 2017 aveva sconfitto la candidata nazionalpopulista Marine Le Pen, la Francia in un primo tempo è parsa al sicuro da questa perturbazione. “La vittoria di Emmanuel Macron alle elezioni per la presidenza francese dimostra senza ombra di dubbio che il domino populista nelle economie avanzate fuori dal mondo anglosassone non ha nemmeno rischiato di cadere”, ha dichiarato nel maggio 2017 Jacob Funk Kirkegaard, senior fellow al Peterson Institute for International Economics (PIIE), un think tank di Washington DC che si occupa di libero mercato, in un articolo intitolato “Macron’s Victory Signals Reform in France and a Stronger Europe”.
A distanza di quasi un anno, nell’aprile 2018, Will Marshall del Progressive Policy Institute, ideatore del movimento New Democrat collegato ai Clinton, ha pubblicato su Politico un articolo intitolato “How Emmanuel Macron Became the New Leader of the Free World”, nel quale ha sostenuto che il presidente francese era la prova tangibile che i centristi neo-libersisti favorevoli al mercato avrebbero potuto sconfiggere le forze del populismo e del nazionalismo.
Poi, all’inizio del mese di novembre di quello stesso anno, alcune proteste – indirizzate in un primo tempo contro l’impatto che avrebbe avuto l’aumento dei prezzi dei carburanti sui cittadini francesi delle periferie, delle campagne e della classe operaia – sono degenerate in mesi di scontri violenti tra poliziotti e contestatori che hanno invaso il centro di Parigi con gas lacrimogeni e automobili date alle fiamme, moltiplicando i cortei di contestazione in tutta la Francia.
“Si tratta dunque di una rivolta?”
“No, maestà: è una rivoluzione.”
Proprio così: Europa e America del Nord stanno vivendo la più vasta ondata rivoluzionaria di proteste politiche dagli anni Sessanta, o forse dagli anni Trenta. Solo che in Francia, per il momento, la rivoluzione transatlantica è ancora nonviolenta. In ogni caso, si tratta proprio di una rivoluzione.
Uno degli slogan dei radicali degli anni Sessanta era: Il problema non è il problema. Se i problemi di oggi che infiammano soprattutto il populismo della classe dei lavoratori nativa di Paesi particolari – l’immigrazione e gli scambi commerciali per Trump, l’immigrazione e la sovranità per i sostenitori della Brexit, le alte percentuali di musulmani tra gli immigrati per i populisti tedeschi e scandinavi, il costo del carburante e altre questioni di politica interna, le cui spese ricadono perlopiù sulla classe operaia delle periferie, nel caso dei Gilet gialli francesi – non sono il problema, allora qual è il problema?
Il problema è il potere. Il potere sociale si esprime in tre àmbiti: il governo, l’economia, la cultura. Ciascuno di questi tre àmbiti del potere sociale è sede di una lotta di classe – uno scontro talora intenso, talvolta tenuto a freno da compromessi trasversali. Tutti e tre gli àmbiti della società occidentale odierna sono fronti di guerra della nuova lotta di classe.
La prima lotta di classe in Occidente cominciò un secolo e mezzo fa, nelle fasi iniziali del processo di industrializzazione, quando la struttura sociale agraria premoderna andò in pezzi per l’affermarsi di due importanti classi sociali moderne: da un lato chi lavorava nelle fabbriche e nel settore dei servizi, dall’altro i capitalisti borghesi, ai quali in seguito si unirono dirigenti e professionisti con credenziali accademiche. Le riforme furono parziali e circoscritte, fino a quando l’imperativo di mobilitare l’intera popolazione nazionale per la guerra non rese indispensabile porre fine alla lotta di classe.
Durante e dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti e i loro alleati europei adottarono, spesso sulla base di precedenti del tempo di guerra, alcune versioni di quello che in questo libro chiamo pluralismo democratico. Nell’America di Truman e di Eisenhower, nella Germania di Adenauer, nella Gran Bretagna di Churchill e in altre democrazie occidentali, i mediatori del potere che rispondevano del loro operato all’elettorato della classe operaia e rurale – politici di partiti affermatisi dal basso, capi di sindacati dei lavoratori, esponenti di punta di associazioni agricole e religiose – contrattarono con le élite nazionali nei tre ambiti del governo, dell’economia e della cultura. Nell’era del pluralismo democratico, le società delle regioni nordatlantiche hanno goduto del benessere di massa e ridotto le disuguaglianze.
Tra gli anni Sessanta e oggi – quando il timore decrescente di un conflitto tra grandi potenze poco alla volta ha ridotto gli incentivi per le élite occidentali a fare concessioni alle classi operaie occidentali – il sistema postbellico è stato smantellato con una rivoluzione dall’alto, che ha sostenuto gli interessi materiali e i valori intangibili della minoranza di manager e professionisti con un’istruzione universitaria, subentrati come élite dominante ai capitalisti borghesi di un tempo.
Il pluralismo democratico è stato sostituito da quello che potremmo chiamare neoliberismo tecnocratico. Nell’àmbito dell’economia, le grandi aziende hanno incoraggiato la desindacalizzazione e la deregolamentazione del mercato del lavoro a discapito dei lavoratori. Le aziende hanno anche accolto l’arbitraggio globale del lavoro, delocalizzando la produzione a lavoratori poveri fuori dai confini del Paese o assumendo lavoratori immigrati, per indebolire i sindacati locali e sottrarsi ai vincoli delle normative nazionali sul lavoro.
Nel frattempo, negli ambiti della politica e del governo, ai partiti che in origine erano federazioni nazionali di organizzazioni locali con affiliazioni di massa, sono subentrati partiti controllati da donatori e consulenti dei media. Allo stesso tempo, molti dei poteri delle legislazioni nazionali democratiche sono stati usurpati da, o delegati a, agenzie esecutive, tribunali, oppure enti transnazionali sui quali i professionisti con un’istruzione universitaria hanno un’influenza di gran lunga superiore a quella della maggioranza formata dalla classe operaia, nata in loco o all’estero.
Infine, nell’àmbito della cultura – media e pubblica istruzione inclusi – gli organi di vigilanza religiosi e civici hanno perso potere, spesso in conseguenza dell’attivismo di giudici membri dell’élite sociale, che condividono opinioni libertarie su società ed economia con i loro pari che hanno un’istruzione universitaria.
La rivoluzione neoliberista tecnocratica dall’alto, combattuta in una nazione occidentale dopo l’altra da membri di una élite manageriale sempre più aggressiva e potente, ha provocato una controreazione populista dal basso da parte della classe operaia nazionale, sempre più esautorata e sulla difensiva, costituita perlopiù da non bianchi (una minoranza sostanziale di elettori britannici neri e di varie etnie di colore ha appoggiato la Brexit, mentre si calcola che nel 2016 abbia votato per Trump il 26 per cento degli americani di origine centroamericana).
Dopo essersi resi conto che i sistemi politici delle loro nazioni erano corrotti e che i partiti mainstream avrebbero continuato a ignorare i loro interessi e valori, gli elettori della classe operaia estraniata hanno trovato in qualche caso improbabili paladini tra i demagoghi populisti come Donald Trump, Nigel Farage, Boris Johnson, Marine Le Pen e Matteo Salvini.
Nonostante le molteplici differenze, questi demagoghi populisti hanno sferrato contrattacchi simili agli establishment neoliberisti dominanti in tutti e tre gli àmbiti del potere sociale. Nell’àmbito dell’economia, i populisti sono favorevoli a restrizioni nazionali agli scambi commerciali e all’immigrazione, per fare da scudo ai lavoratori rispetto alla concorrenza delle importazioni e degli immigrati. Nell’àmbito della politica, i populisti accusano i partiti e le fazioni neoliberisti di corruzione ed elitarismo. Nell’àmbito della cultura, infine, i populisti denunciano il multiculturalismo e il globalismo promulgati dalle élite, trasgredendo di proposito all’etichetta del politically correct che contraddistingue l’appartenenza all’élite manageriale con un’istruzione universitaria.
I populisti in Europa e in America del Nord riusciranno a sovvertire e sostituire il neoliberismo tecnocratico? Quasi certamente no. Gli elettori populisti sono una percentuale considerevole e stabile degli elettori occidentali, ma sono soltanto una componente elettorale di società pluralistiche con sistemi politici sempre più frammentati.
Oltretutto, i demagoghi populisti tendono alla ciarlataneria. Spesso sono corrotti. Molti sono razzisti o etnocentrici, anche se spesso queste caratteristiche sono esagerate dai critici dell’establishment, che li mettono sullo stesso piano di Mussolini e Hitler. Se i populisti demagoghi riescono in qualche caso isolato ad aggiudicare la vittoria ai loro elettori, la Storia ci insegna che i movimenti populisti hanno maggiori probabilità di fallire quando si trovano a dover affrontare classi dominanti ben radicate, i cui membri traggono beneficio da un monopolio pressoché esclusivo di competenze, ricchezze e ascendente culturale.
Come reazione alle ribellioni populiste dal basso, le élite manageriali di vari Paesi occidentali potrebbero indirizzarsi verso una repressione vera e propria della classe operaia, limitando l’accesso all’attività politica e ai media a tutti i dissidenti, non soltanto a quelli populisti. In alternativa, le classi manageriali al governo potrebbero cercare di cooptare i ribelli populisti facendo loro concessioni secondarie sull’immigrazione, gli scambi commerciali o la politica interna.
Tuttavia, è improbabile che spartire la ricchezza con la ridistribuzione e con gesti simbolici di cortesia possa porre fine alla nuova lotta di classe, se l’esigua superclasse manageriale non sarà disposta a condividere davvero il potere con la maggioranza della popolazione appartenente alla classe dei lavoratori. Per perseguire un’autentica pace di classe nelle democrazie occidentali sarà imprescindibile unire e dotare di pieni poteri sia i lavoratori immigrati sia quelli nativi, e nel frattempo ripristinare un autentico potere decisionale per la maggioranza priva di un’istruzione universitaria in tutti e tre gli àmbiti del potere sociale: l’economia, la politica e la cultura.
Il populismo demagogico è un sintomo. Il neoliberismo tecnocratico è la malattia. Il pluralismo democratico è la cura.
In alto, Charles Thévenin, The Storming of the Bastille (Francia, 1790), Severance and Greta Millikin Trust – Cleveland Museum of Art